
Littlehampton, West Sussex, Regno Unito, 1922. La vita di Edith Swan (Olivia Colman), cinquantenne timorata di Dio che vive con i genitori, è sconvolta dal ricevimento di varie lettere anonime, contenenti commenti osceni nei suoi confronti. Papà Edward (Timothy Spall) non ha dubbi, le avrà certo inviate la disinibita vicina di casa Rose Gooding (Jessie Buckley), irlandese vedova di guerra, da poco trasferitasi in Inghilterra, insieme alla figlia Nancy (Alisha Weir) e al compagno Bill (Malachi Kirby), che viene così denunciata e incarcerata in attesa del processo, visto che non può pagare la prevista cauzione di tre sterline.
Vi provvederanno le sue tre amiche Ann (Joanna Scanlan), Kate (Lolly Adefope) e Mabel (Eileen Atkins). Ma una volta che uscirà di prigione i sospetti su Rose andranno ad acuirsi, in quanto le lettere dal contenuto volgare riprenderanno ad essere inviate e non solo ad Edith, ma a molte persone del paese.

L’unica difesa avanzata dall’irruente irlandese, che, scandalizzando i benpensanti, non disdegna bevute e partite a freccette al pub, oltre a fumare e a non fare segreto dei suoi sentimenti nei confronti di Bill, è data dalla circostanza di come lei abbia sempre preferito parlare a viso aperto, non certo dietro le spalle. All’interno del locale distretto di Polizia solo l’agente Gladys Moss (Anjana Vasan) nutre dei dubbi riguardo la sua colpevolezza, notando come la grafia di Rose sia del tutto diversa da quella delle missive, ma viene zittita dal suo superiore, per poi essere sospesa dal servizio.
Inizierà allora ad indagare per proprio conto, con l’aiuto delle tre amiche di Rose … Da amante delle commedie classiche, caratterizzate da un buon lavoro di scrittura, una regia attenta e valide interpretazioni attoriali, così come di quell’umorismo inglese che sa essere tanto sottile quanto amaramente sarcastico nel ritrarre la quotidianità, non potevo che restare affascinato da Wicked Little Letters, film la cui sceneggiatura, opera di Jonny Sweet, è ispirata ad una storia vera (“più vera di quanto pensiate”, recita una didascalia sui titoli di testa).

La regia è di Thea Sharrock, sagace nel mescolare ironia e dramma, assicurando loro identica portata nel sostenere una messa in scena piacevolmente teatrale, che può ricordare, credo sia stato già notato da molti, i gialli di Agatha Christie. L’Inghilterra dei primi anni ’20, che porta sulle spalle i segni del Primo Conflitto e gli strascichi di un dispotico patriarcato, appare rappresentata dalla figura del bizzoco Edward (l’ottimo Spall): trafitto dal dolore per i due figli morti in guerra, si rende simbolo di quella refrattarietà nei confronti degli sconvolgenti mutamenti prospettati, tra l’altro, dal movimento delle Suffragette nel rivendicare l’affermazione di una sacrosanta eguaglianza tra uomini e donne.
Su questo sfondo, sospeso tra vetustà e innovazione, conformismo e aneliti di ribellione, ecco stagliarsi e contrapporsi tre caratteri del tutto diversi, inerenti a tre donne intese a porre in essere una battaglia rivendicativa della propria individualità e propense a voler assimilare ciascuna una parte dell’altra, così da attutire le reciproche spigolosità.

La scatenata Rose, che autodeterminazione ed emancipazione le ha conquistate da sé, fregandosene del perbenismo imperante, perlopiù di facciata, vorrebbe, forse inconsciamente, possedere quell’avvedutezza propria di Edith, la quale tende ad adeguarsi passivamente, con più di un acre rimpianto, a quei canoni comportamentali prefissati, rientranti nel catalogo di quanto ci si aspetta da una donna del tempo, mentre nel suo intimo anela ad esternare la spregiudicatezza propria di Rose, con la quale d’altra parte, almeno inizialmente, stringe un rapporto amicale, ribellandosi poi all’autorità paterna con modalità del tutto originali, intese a far deflagrare quanto necessario a scuotere l’ordinaria ritualità della cittadina, ponendo i suoi abitanti di fronte ai loro limiti ideologici e comportamentali.
Gladys infine, cui Anjana Vasan offre tutta la potenza espressiva di uno sguardo che alterna compatimento e desiderio di riscatto nei confronti delle figure maschili, lotta, nel ricordo del babbo anche lui poliziotto, in nome di un personale fiuto investigativo, consapevole di ciò che rappresenta la sua figura (la denominazione “agente poliziotto donna”, in parte diritto acquisito, in parte discriminazione, almeno vista con gli occhi odierni), anche nei limiti di un regolamento che le impedisce di essere moglie e madre.

La sceneggiatura sceglie di giocare quasi fin da subito la non facile carta di svelare il colpevole delle terribili missive, facendo sì che la tensione s’insinui sottilmente negli spettatori in base al prospetto della possibilità che possa essere consegnato alla giustizia, ove i piani di Gladys giungessero a buon fine e vi fosse l’accettazione da parte dello stolido superiore, pur nell’avere contravvenuto alle sue disposizioni.
La regia, sostenuta anche dalle variabili scelte cromatiche della fotografia (Ben Davis) e dal montaggio (Melanie Oliver), riesce quindi a movimentare non di poco l’azione, mantenendosi nei canoni di una nitida classicità, diversificando le inquadrature relative alle due protagoniste principali, variabili e movimentate nel seguire il ciclone Rose, più statiche quando vi è da riprendere Edith e la sua famiglia, assecondandone le rigidità posturali e comportamentali, mentre Davis opta al riguardo per tonalità fosche, tetre, a simboleggiare l’oscurantismo proprio di un credo indottrinato dall’alto.
Andando a concludere, credo che Wicked Little Letters riesca a centrare il bersaglio di una satira incisiva e a tratti cattiva, che guarda sì al passato, ma per parlarci dell’oggi, dove il veleno nei confronti del prossimo viene esternato via social e conclamato a suon di like, per non parlare dell’omologante e fin troppo esibito “politicamente corretto” o della retriva stolidità maschilista tuttora rinvenibile in vari settori della società, anche, se non soprattutto, in forma latente, concludendo con la necessità di rinvenire, sempre e comunque, un nemico cui addebitare i propri fallimenti, le proprie colpe ed insicurezze esistenziali (“spesso er nemico è l’ombra che se crea pe’ conservà un’idea: nun c’è mica bisogno che ci sia”, Trilussa, Er nemmico) .




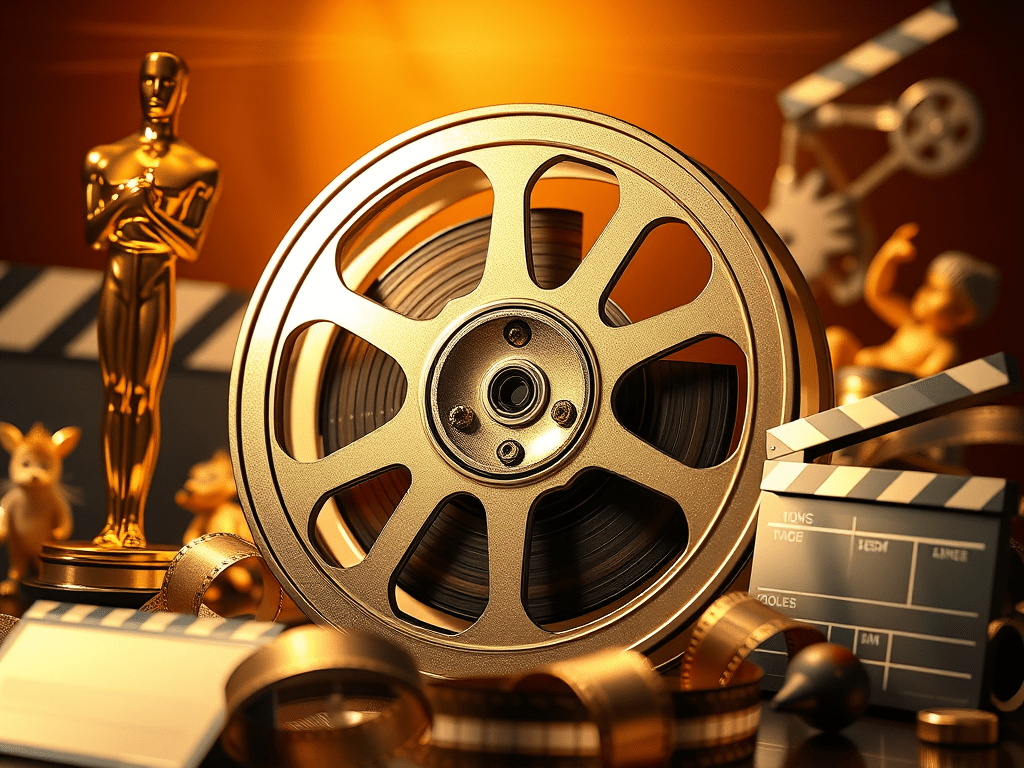

Lascia un commento