La lettura del nuovo libro di Claudio Sottocornola, A bordo. Cronache di navigazione a vista, edito da Gammarò mi ha suscitato varie riflessioni, che ho inteso condividere con l’autore per il tramite dell’intervista che potete leggere qui di seguito.
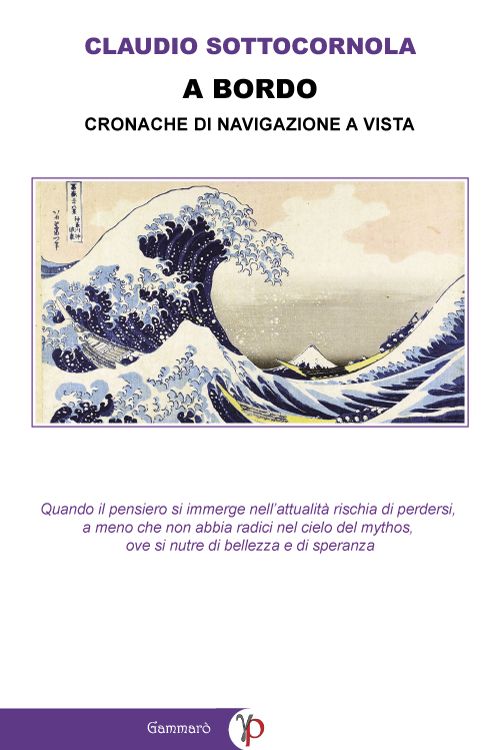
Claudio, nel leggere il tuo ultimo libro, “A bordo. Cronache di navigazione a vista”, ho avuto la sensazione che tu abbia avvertito la necessità, direi anche l’urgenza, di “scendere in campo”, volgendo il tuo sguardo da moderno filosofo all’attuale situazione politico-sociale, italiana in particolare. Parlaci allora di quanto ti ha motivato a dare vita a questa raccolta di impressioni critiche inerenti la nostra quotidianità.
“In realtà, in questo lavoro ho voluto raccogliere scritti diversi, alcuni ancora inediti, che sono stati redatti dal 2022 al 2024 in rapporto a stimoli dell’attualità e del quotidiano, dalla guerra in Ucraina al dibattito politico in Italia, dalle disfunzioni della nostra burocrazia alla crisi della Chiesa cattolica, dalla ipertrofia social e mass mediatica alle controversie relative ai gender studies, per parlare poi anche di musica, bellezza e mito, come possibili orizzonti di senso in un mondo tanto tormentato. Mi è sembrato utile intrecciare biografia, storia e attualità, testimoniando esperienze che spero aiutino a sfatare luoghi comuni, cliché, pregiudizi, che colgo come dominanti nel cosiddetto mainstream, il pensiero liofilizzato, lobotomizzato e banalizzato dato in nutrimento alle masse, sempre più ignare, ignave e incarognite”.
Tra i tanti argomenti, la tua attenzione si volge anche alla contrapposizione, sempre all’ordine del giorno, fra destra e sinistra, che personalmente vedo quali due “eserciti l’un contro l’altro armati”, l’una volta a mettere in discussione determinati diritti acquisiti nel tempo, l’altra che le si para contro spesso per il solo piacere di opporsi. Colleghi tale conflitto ai movimenti del ’68 e alla crisi delle ideologie dopo la caduta del Muro di Berlino, ma vorrei lanciarti una provocazione: dopo gli accadimenti dell’8 settembre ’43, non è forse mancata una “Norimberga italiana”?

“Credo che la contrapposizione fra destra e sinistra sia solo un aspetto della banalizzazione del pensiero collettivo corrente. La realtà è composita, varia, eterogenea, e meno male che è così. Purtroppo però la semplificazione bipolare permette un approccio calcistico, quando non settario, dove a chi vive di sola appartenenza sembra chiaro da che parte stanno i cattivi – dall’altra ovviamente –, e altrettanto chiara appare la propria presunta superiorità morale, convinzione che genera gratificazione psicologica e arroganza comportamentale. In questo senso non vedo la contrapposizione fra destra e sinistra focalizzata tanto sui diritti, ma piuttosto sul rapporto fra tradizione e utopia, in realtà ambedue necessarie allo sviluppo storico: senza radici non crescono le chiome degli alberi, e non è tagliando il tronco che si dà vita all’albero.
L’Italia contemporanea è Paese nato dalla contrapposizione, e paradossalmente non ha mai avuto un mythos condiviso: il Risorgimento è stato spesso visto al Sud come un processo di occupazione e assimilazione, la Resistenza, pur politicamente trasversale, non è riuscita a produrre un immaginario davvero comune. Paradossalmente, la Prima Repubblica è stata forse più lungimirante nel generare una prassi politica che – grazie alla forza del partito di maggioranza relativa, la Democrazia Cristiana – tendeva ad accorpare le forze politiche a partire dal centro, dunque smussando gli estremi e cercando una sintesi, mentre l’attuale bipolarismo italiano – e occidentale in genere –, favorisce accorpamenti che, di necessità, devono includere anche le posizioni più estreme, con l’effetto di spaccare ancor più la compagine politica a metà, e di generare una lotta politica aggressiva e feroce. Ma da Palmiro Togliatti, storico leader del Partito Comunista post bellico, ad Alcide de Gasperi, segretario della coeva Democrazia Cristiana, la capacità di gestione del conflitto di quella classe politica era ben altra, come testimonia la famosa amnistia verso i soggetti compromessi col precedente regime voluta dallo stesso Togliatti.
D’altra parte, come sottolinea anche Hannah Arendt, dobbiamo riconoscere che altra cosa furono il nazismo tedesco e il comunismo sovietico, con milioni di vittime di regime acclarate, rispetto al fascismo italiano, definito non a caso da uno storico acuto come Giovanni Sabbatucci un totalitarismo imperfetto, per il contrappeso che, in qualche misura, su di esso esercitavano la monarchia e la Chiesa cattolica. Quanto al giudizio etico, ricordiamo poi che l’Italia di allora – rurale, patriarcale, cattolica, poco scolarizzata, emergente dal trauma della Grande Guerra con i suoi morti, mutilati e disoccupati di ritorno – nulla aveva a che spartire con quella di oggi. E lo aveva ben capito Renzo De Felice, studioso che, a partire dagli anni ’60 del ’900, procede ad una attenta storicizzazione del fenomeno, sostenendo che esso fosse ormai scomparso senza alcuna possibilità di riprodursi, visto il mutato contesto, e condannando l’estensione del concetto di fascista ad ogni dittatura, che finisse con l’identificare il fascismo con una sorta di metastorico male assoluto, privo però di quella consistenza effettiva che sta, al contrario, nel suo carattere storico e limitato.
Stante quindi la grande differenza, anche solo in termini di vittime provocate, che separa nazismo e stalinismo da un lato, e fascismo dall’altro, pur senza negare le violenze e nefandezze che esso produsse, ritengo sia stato un bene non avere una Norimberga italiana, che forse avrebbe finito con l’avallare vendette personali più che giustizia riparativa, come purtroppo ci rammenta tanta storia sotterranea di quegli anni”.
Si suole dire che “con i se e con i ma non si fa la Storia”, mi piacerebbe però invitarti a visualizzare una particolare ucronia: cosa sarebbe accaduto nel nostro paese e quali ripercussioni avrebbe poi avuto a livello mondiale se si fosse concretizzato quel compromesso storico prospettato da Enrico Berlinguer con Aldo Moro? Si sarebbe evitato il progressivo distacco tra istituzioni e cittadini e, soprattutto, avrebbe trovato ugualmente spazio quella personalizzazione della politica, dominante dagli anni ’90 in poi?

“Difficile la fantapolitica o fantastoria… Ma qualche indizio l’abbiamo, per esempio a livello di macrosistemi internazionali. Con la caduta del Muro di Berlino, nel 1989, tutti credevano che fosse arrivata la fine della Storia e l’avvento di un dominio assoluto del Mercato, che avrebbe garantito il sistema capitalistico ad libitum e senza più concorrenti, e in parte è andata così. Con un correttivo però, dovuto alla assimilazione di molte istanze della cultura marxiana che, attraverso i movimenti del ’68, è penetrata nella tradizione liberale occidentale permeandone le future classi dirigenti. Così se il liberalismo tende all’esaltazione dell’individuo e dei suoi bisogni, il marxismo sostiene l’eguaglianza degli individui e dei loro bisogni. Ma accumulo di capitale e condivisione di capitale sono solo due facce della stessa medaglia, ovvero una lettura economica della realtà, che caratterizza proprio il nostro tardo-capitalismo, con il suo approccio quantitativo, funzionalistico e produttivistico alla realtà, ove al cittadino subentra il consumatore e alla rivoluzione il diritto allo shopping per tutti.
La retorica dei diritti politically correct rimane allora in tale contesto solo un’algida scenografia, funzionale al buon andamento del mercato. Il Graecia capta ferum victorem cepit, di oraziana memoria, sembra dunque attagliarsi bene al rapporto fra marxismo, apparentemente sconfitto, e capitalismo, apparentemente vittorioso, in realtà ambedue proiettati verso un futuro tecnocratico-digitale, evocato dal grande filosofo Emanuele Severino come punto d’arrivo dell’approccio predatorio sotteso all’economicismo materialista dominante, a sua volta espressione del rapporto di dominio instaurato dall’Occidente sull’Essere. Ma tornando all’Italia, con la crisi della Prima Repubblica seguente a Tangentopoli, e l’assimilazione di una parte del mondo cattolico proveniente dalla dissolta Democrazia Cristiana alla Sinistra moderata e quindi al PD, possiamo dire che quel compromesso storico da te evocato si sia realizzato, proprio sulla falsariga dello scenario internazionale citato, con esiti analogamente penalizzanti per ambedue le parti in causa, private di un’identità specifica e, in assenza di ciò, costrette, di rimbalzo, a un approccio esclusivamente quantitativo e funzionalistico alla realtà, talvolta ineccepibile sul piano formale ma sostanzialmente distante dal sentiment di masse che forse inconsciamente cercano più ideali da condividere che bonus da intascare.
Ma oggi purtroppo prevale un’istanza riduzionistica in politica, intesa come mera amministrazione di risorse, secondo la sintesi marxiano-capitalista di cui si è detto, istanza che della politica ignora purtroppo l’afflato ideale, che per Platone avrebbe invece dovuto caratterizzarla come la più nobile delle attività umane. In tale prospettiva, più che la contrapposizione banalizzante di destra/sinistra, in ottica orizzontale e conflittuale, a muovere sarebbe la spinta verticale verso l’eccellenza del valore che, se perseguito da ogni parte politica, produrrebbe senz’altro rispetto, collaborazione, dissenso civile e dialogante. Ma si tratta ovviamente di un sogno”.
Tra una politica ormai “bignamizzata” in slogan pronto uso, studiate frasi acchiappa like e personificazione divisiva, a rimarcare un gretto egoismo orfano di qualsiasi riferimento sociale e morale, nelle pagine di “A bordo” evidenzi come si sia perso di vista un concreto pericolo, il tecnicismo che avvolge ormai ogni attività umana e la sua congiunzione col neo liberismo economico. Come venirne fuori?
“Severino, che ho citato sopra, sostiene che l’orizzonte destinale della nostra civiltà non è il marxismo e non è il capitalismo, ma l’avvento di una tecnocrazia digitale che assimilerà ogni contrasto e opposizione entro l’algido regno di un controllo tecnico dell’umano totalizzante e pervasivo, rispetto al quale i totalitarismi novecenteschi di cui abbiamo parlato sembreranno rozzi reperti archeologici del passato, nel confronto con un presente triste e distopico. In quel momento l’essere umano avrà probabilmente risolto ogni problema pratico, ma non quello del senso e della morte, che alla fine dissolverà la bolla tecnologica da cui sarà avvolto come ininfluente, riaprendolo alla domanda sull’Essere e, con essa, a una qualche speranza di salvezza. Ciò che noi possiamo fare, sin da ora, è però lavorare perché tale domanda di senso sia posta, e dunque perché le coscienze, opponendosi al dominio del quantitativo, si formino alla qualità, alla percezione della bellezza, del bene e del vero, attraverso pensiero, arte, spiritualità, relazioni sociali di rispetto e amicizia”.
Anche la Chiesa Cattolica, al pari di altre confessioni religiose, appare ormai stretta tra le spire dell’appartenenza e dell’esclusività fideistica, in nome di una rigida istituzionalizzazione. Cosa l’ha condotta lontano da quanto professava il rabbi di Nazareth, “Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, ed io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore; e voi troverete riposo per le anime vostre; poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero”?

“In effetti, per chi abbia vissuto gli anni ’60 e ’70 del ’900, così ricchi di stimoli culturali e fermenti spirituali, connessi – in ambito religioso – al Concilio Vaticano II, che si svolse dall’11 ottobre 1962 all’8 dicembre 1965, risalta, per contrasto, la condizione di stanco ristagnare del mondo cattolico contemporaneo, che sembra aver molto diluito la profondità del dibattito di allora, a favore di un’adeguazione agli standard comunicativi e aggreganti dei mass e social media di oggi, con un impoverimento non da poco del linguaggio, delle proposte, dell’esegesi biblica e della direzione spirituale. Si cerca insomma molto più appartenenza che verità, e per far ciò si strizza l’occhio a una sorta di marketing comunicativo in cui sembra proprio l’algoritmo dei consensi a dettar legge.
E il risultato qual è? Un doping dell’immagine istituzionale che vede manifestazioni di massa, rinviate da social e teleschermi, con papi benedicenti, e chiese vuote, chiuse, abbandonate, oratori ad uso di società sportive e aspiranti calciatori, preti incerti fra anacronismi tridentini, movimentismo politico-sociale e velleitari protagonismi mediatico-culturali, ma sostanzialmente indifferenti alla vecchia “cura d’anime”. I giovani fanno riferimento ad altri paradigmi piuttosto che a quello cristiano e le assemblee domenicali, sempre più esigue, vedono una netta prevalenza di anziani e pensionati. Non possiamo d’altra parte nasconderci che, sorprendentemente, dopo le illusioni di globalizzazione e planetarizzazione dell’esistenza, e forse in reazione ad esse, a prevalere in tutto il mondo sono le forme integralistiche e involute della religiosità. Personalmente sono tuttavia poco attratto dal tema – sempre ricorrente – del ritorno alle origini. E devo necessariamente spiegarmi anche con qualche riferimento teologico.
Nei primi secoli dell’era cristiana, quando andava definito il nucleo essenziale della fede, per esempio attraverso i primi concili ecumenici, come quelli di Nicea, Costantinopoli, Efeso e Calcedonia, il cristianesimo andava a strutturarsi attraverso i suoi dogmi, più come una filosofia che come un’esperienza storica, e questo produsse una raffinatissima elaborazione teoretica, che portò a compimento il processo di cristificazione di Gesù di Nazareth, ovvero, alla fine, la sua identificazione col Logos greco, con la figura della Sapienza antico-testamentaria, con la Seconda Persona della Trinità. Questa imponente costruzione permetteva e, in certo qual modo, permetterebbe ancora oggi, di trascendere la dimensione puramente storica dell’uomo-Gesù, per cogliere in lui l’icona del divino, la manifestazione di quel Logos che, in filigrana, andrebbe a significare la Parola originaria e il Senso ultimo di ogni realtà creata.
Questa concezione ha consentito alla Chiesa, nei secoli, di leggere e vivere la propria storia come una specie di Incarnazione continua di quel Logos e dunque come un inarrestabile processo di cristificazione di tutto l’esistente, ove ogni credente sarebbe chiamato a propria volta a divenire una sorta di Alter Christus. Tale concezione, rafforzata con la grande filosofia medievale, da Agostino di Ippona a Tommaso d’Aquino, si concentra dunque più sul Cristo-Logos che sul Gesù storico, ed ha, a mio parere, l’enorme merito di contestualizzare la figura dello stesso Gesù, altrimenti ridotto a una sorta di modello imitativo magari sostituibile, per concentrarsi sull’esperienza del divino a cui egli dovrebbe rinviare, esattamente come il dito che indica la luna. Questa formazione culturale, che subordina il discorso sul Gesù storico a quello sul Cristo-Logos trinitario, mi sembra tuttavia molto relativizzata nella formazione del clero di oggi che, attingendo a parametri più soggettivistici e fideistici, tende a concentrarsi su Gesù come individuo storico da imitare, il quale tuttavia non potrebbe che esprimere, in quanto “vero uomo” (la sua “divinità”, per il credente, non ne intacca in alcun modo l’umanità), anche la fisionomia e i condizionamenti culturali del proprio tempo (un esempio su tutti: Gesù non poteva avere una cultura scientifica), con esiti piuttosto riduttivistici.
Dunque per me il Cristo-Logos è invece rintracciabile soprattutto in quel deposito di esperienze che, a partire dalla narrazione biblica, si è riversato nel nostro immaginario condiviso, dalla Cappella Sistina a Bach, dal Canto Gregoriano alla Divina Commedia, dalle grandi cattedrali gotiche alla teologia di von Balthasar, ma anche nel nostro diritto, in una certa idea di politica e di persona, in innumerevoli opere assistenziali e missionarie. Ecco perché condivido la posizione del filosofo polacco Leszek Kołakowski che, in Gesù. Saggio apologetico e scettico (Le Lettere, 2023), nonostante il suo agnosticismo marxiano, sostiene la centralità di Gesù non tanto come soggetto storico concreto, ma come paradigma etico fondativo della civiltà occidentale, il cui vissuto, dall’arte al pensiero al diritto, sarebbe in esso fortemente radicato, tanto che, venendo meno quel paradigma, l’intera struttura vacillerebbe, non riuscendo più a motivarsi adeguatamente.
Allora anch’io, con Kołakowski, penso che non si debba in primis tornare al Gesù individuo vissuto 2000 anni fa, ma coglierne la presenza, l’eredità e gli sviluppi, in quanto Cristo-Logos, nella grande arte, nella grande politica, nella grande spiritualità. E non dimentichiamo che la sua eredità più sublime sta non tanto in qualche risultato di natura pubblica, ma nel richiamo alla nostra ontologia profonda, a quel bene dell’anima che oggi sembra dimenticato da tanti, anche dal clero, e che costituisce invece la perla preziosa di cui Gesù parla in una sua celebre parabola (Mt 13,45-46). È dunque nel tempo presente che dobbiamo impegnarci per vivere questa memoria e questa fedeltà, che è, più che adesione confessionale, memoria e fedeltà alla propria storia”.
Concludo l’intervista riportando una frase del buon vecchio Woody (Allen): “L’umanità si trova oggi ad un bivio: una via conduce alla disperazione, l’altra all’estinzione totale. Speriamo di avere la saggezza di scegliere bene”. Alla luce delle tue costanti osservazioni sul reale, così come riportate anche tra le pagine di “A bordo”, hai una terza via da suggerire?
“Il futuro non è già scritto. Il tempo presente è il nostro spazio di gioco. Divertiamoci a porre condizioni di grazia, eleganza e sobrietà nell’inventare la vita!”.





Lascia un commento