
Amman, Giordania, tempi nostri. La vita della trentenne Nawal (Mouna Hawa) viene sconvolta dalla morte improvvisa del marito Adnan (Mohammad Suliman). Si ritrova sola, con una figlia di sei anni circa, Nora (Celina Rababah), a fronteggiare le rigide regole imposte per il lutto: non potrà uscire di casa per quattro mesi lunari e dieci giorni, fatti salvi casi di necessità o particolari doveri e dovrà rientrare prima che tramonti il sole.
Le è quindi possibile recarsi a fare la spesa, accompagnare la bambina a scuola e, soprattutto, continuare a lavorare come badante di un’anziana signora, presso un’agiata famiglia. Sulla già difficoltosa prosecuzione della consueta quotidianità va poi a pesare quanto ulteriormente sancito dalla Sharia: in mancanza di un figlio maschio, la famiglia del defunto può avanzare pretese sull’eredità, nonché riguardo la custodia di Nora.

Ecco allora che, sostenuto dall’accondiscendenza del fratello di Nawal, il cognato Rifqui (Haitham Omari) le intima il pagamento delle restanti quattro rate del pick-up acquistato dal defunto Adnan o che, in mancanza, il mezzo venga messo in vendita. In aggiunta, chiede poi la cessione in favore della sua famiglia dell’appartamento, considerando come la donna non abbia in mano un documento che possa provare di aver anch’essa contribuito a mettere su la somma necessaria ad ottenere il mutuo per l’acquisto.
Nawal però si oppone con fierezza a tale ordine delle cose, una rigidità legale orfana del contraltare di una misericordia propriamente umana, arrivando infine a mentire per ottenere una dilazione riguardo l’applicazione della legge, dichiarando di essere incinta, con la possibilità, inshallah, che possa venire alla luce un maschio…
Primo film giordano presentato al Festival di Cannes, lo scorso anno, all’interno della 62ma Semaine de la Critique, dove ha conseguito il Premio Gan per la distribuzione e il Premio Rail d’ Or, dopo l’assegnazione del Premio La Biennale di Venezia Final Cut in Venice come Migliore work in progress e candidato, tra l’altro, all’ Oscar per la Giordania, Inshallah a Boy vede alla regia Amjad Al-Rasheed, anche autore della sceneggiatura insieme a Rula Nasser e Delphine Agut.
Siamo di fronte ad un’opera che, proprio in virtù di una compiuta ed efficace sinergia tra direzione, scrittura ed ottime interpretazioni attoriali, rilevanti nell’avallare la psicologia dei personaggi, dalla protagonista Mouna Hawa ai ruoli secondari, pone alla luce del sole una determinata situazione oppressiva nei confronti delle donne, nella scia di un patriarcato la cui presunta superiorità assume tutta la consistenza propria di un atavico rituale, anche nell’ottica della quotidianità.
Invita poi noi spettatori a più di una riflessione, scaturente certo dalle situazioni socio-culturali proprie della regione, ma i cui risvolti vanno ad assumere una portata concretamente universale, considerando come anche nei paesi occidentali, circoscritti da un benessere prettamente materiale, orfano di una concreta evoluzione, spesso le varie previsioni legislative non sempre appaiono sufficienti a superare stolidi e retrivi retaggi, vividi o latenti.
Occorre dunque mantenere vivo il fuoco di quella battaglia volta a conquistare una emancipazione, e relativa autodeterminazione, che si vorrebbero patrimonio definitivamente assunto e condiviso, mettendo al bando qualsivoglia negatività al riguardo.
Il sagace lavoro di sceneggiatura fa sì che l’impianto narrativo non vada a circoscriversi esclusivamente all’interno della realtà “casalinga” di Nawal, nel cui ambito si agitano vari segreti (l’abbandono del posto di lavoro da parte del marito, la sua intuibile relazione extraconiugale), andando a comprendervi anche quella propria della famiglia presso cui lavora, di religione cristiana maronita.

Qui avrà modo di confrontarsi e stringere una particolare alleanza con la coetanea Lauren (Yumna Marwan), anche lei costretta ad una asfissiante sottomissione comportante, tra l’altro, su consiglio materno, di accettare i numerosi tradimenti del marito, in nome delle convenzioni rientranti nel comportamento di “una buona moglie”, che prevedono, tra l’altro, il portare avanti una gravidanza non desiderata. Il legame matrimoniale assume anch’esso un risvolto impositivo, un obbligo cui adempiere per poter esprimere liberamente la propria sessualità, ora “sacramentata” e libera dal “marchio del peccato”.
Opportuna visualizzazione, inoltre, viene offerta allo spazio dove Nawal si muove ogni giorno, il mercato, la fermata dell’autobus, le vie cittadine, sempre costretta a lottare duramente per conquistare il diritto ad una emancipazione che la vedrà rifiutare l’aiuto, apparentemente disinteressato, del fisioterapista Hassan (Eslam Al-Awadi).
Farà affidamento, ancor prima che sulla fede, sulla propria caparbietà e sull’amore filiale, nella consapevolezza di poter sconvolgere l’ordinarietà sociale con un “no” che nessuno si aspetta, fino a scoprire come il concetto di moralità possa rivestirsi d’inedite sfumature nell’andare incontro alla realtà.
Diretto con piglio realistico, abbracciando la ritualità giornaliera nel suo insieme, circoscrivendo attraverso accorte inquadrature ambienti e persone, assecondando poi l’incedere “naturale” della narrazione, mediato da una sottesa tensione, Inshallah a Boy credo possa definirsi una realizzazione necessaria, che già dal titolo, ironizzante, mia personale sensazione, su certe “legittime aspettative”, offre la prospettiva di un’inedita speranza, ovvero che non rivesta alcuna importanza il nascere maschio o femmina: ci si affaccia al mondo essenzialmente nella qualità di persona, e in tale veste si andrà a lottare per l’affermazione della propria individualità, nel solco di una diversità eguagliatrice.
Già pubblicato su Lumière e i suoi fratelli-Cultura cinematografica e crossmedialità, foto di copertina: Movieplayer



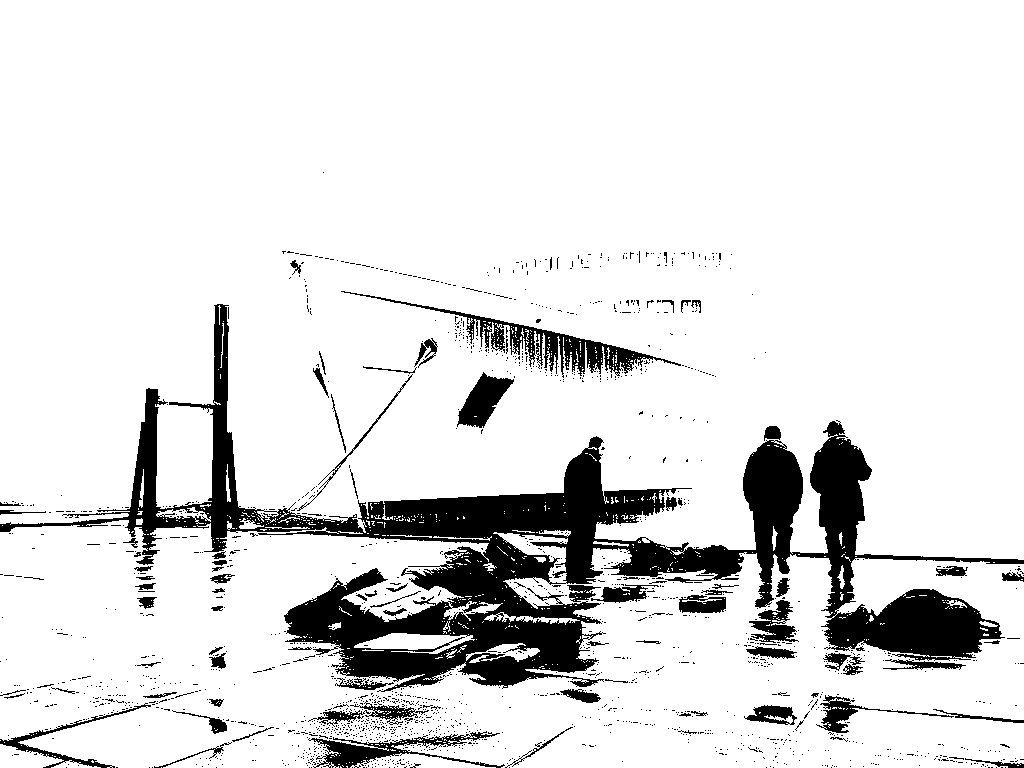

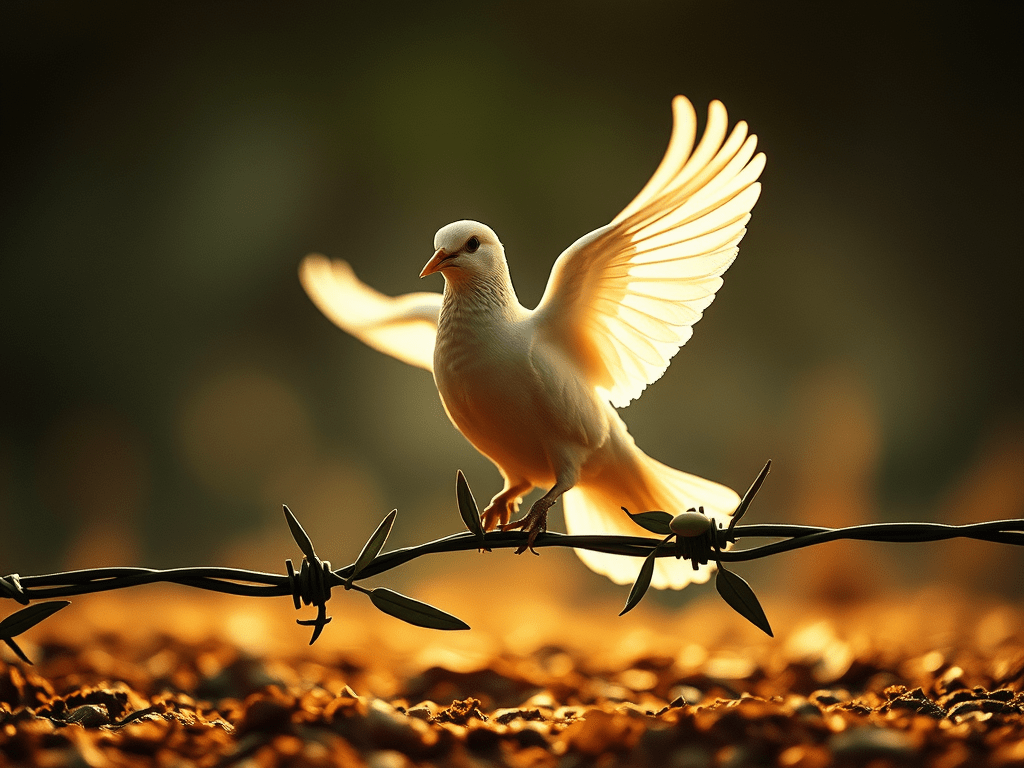
Scrivi una risposta a Magna Graecia Film Festival 21ma edizione, il palmarès – Sunset Boulevard Cancella risposta