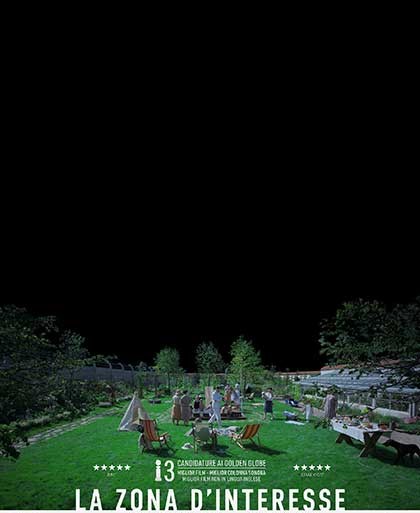
Ho raggruppato all’interno di un unico articolo le mie considerazioni relative ai due film La zona d’interesse e La sala professori, in quanto la loro visione è stata accomunata da sensazioni più o meno simili, rinvenendo in particolare la necessità di metabolizzare le emozioni scaturite in sala, che si sono infine concretizzate dopo qualche giorno, invitandomi ad esternare una serie di riflessioni.
Inizio dunque a scrivere de La zona d’interesse, che vede Jonathan Glazer regista e sceneggiatore nel trarre ispirazione dall’omonimo romanzo di Martin Amis del 2014, in Italia edito da Einaudi. La pellicola ha conseguito il Gran Premio Speciale della Giuria al 76mo Festival di Cannes, per poi essere premiata dai membri dell’ Academy con l’Oscar in qualità di Miglior Film Internazionale e per il Miglior Suono (Tarn Willers e Johnnie Burn).
Se nell’opera letteraria d’origine andava a delinearsi, resa in prima persona, la soggettività propria di diversi individui (militari, collaboratori, detenuti), intesa a condurre la rituale quotidianità con a fianco l’orrore dell’uomo che annienta se stesso, nell’adattamento per il grande schermo il descritto andamento giornaliero viene visualizzato per il tramite dei comportamenti della famiglia Höss, l’ufficiale delle SS Rudolph (Christian Friedel), sua moglie Hedwig (Sandra Hüller), i loro figli.

Vivono in una villa a due piani, con giardino e piscina, situata all’interno della cosiddetta Interessengebiet, ovvero un’aerea di 40 km quadrati adiacente al campo di concentramento di Auschwitz, alla periferia di Oświęcim, in Polonia, di cui il citato Rudolph è il comandante. Il latrare dei cani da guardia, i perentori ordini urlati, qualche sparo, il fumo acre che attraversa l’aria, il sinistro rumore dei forni a pieno regime, le ceneri o i resti di qualche corpo umano che si riversano nelle acque del fiume nei cui pressi la “bella famiglia” si reca per qualche scampagnata, quando non si rivelano utili per la concimazione delle piante, tutto ciò che proviene dal campo, anche pellicce, gioielli o i denti delle vittime idonei a divenire insolita fonte di gioco per i bambini, rientra nell’ottica di una placida normalità.
D’altronde, come dice Hedwig alla madre in visita, la vista di quel brutto muro al confine tra le due strutture verrà provvidamente nascosto da una vite rampicante, mentre intanto Rudolph non può che essere entusiasta del nuovo “piano aziendale” volto ad ottimizzare la resa dei forni…
Glazer alterna efficaci soluzioni visive, penso allo schermo nero in apertura ostentato per tre minuti, a simboleggiare, personale sensazione, la tragicità conferita proprio da quella descritta normalità intesa ad avallare come consuetudine la perdita di qualsivoglia valore che possa definirsi umano, ad un uso straniante e pregnante al contempo del sonoro, del tutto in contrasto, ricercato e voluto, con lo sfruttamento volto al realismo della luce naturale, offerto dalla fotografia di Łukasz Żal.
L’utilizzo poi di dieci telecamere fisse, controllate a distanza da una squadra di cinque operatori, si rende “grande fratello” (nel senso orwelliano del termine) nel restituirci allo sguardo tutto ciò che “naturalmente” si consuma all’interno della lussuosa abitazione, un mondo a parte refrattario a qualsiasi contatto esterno, tranne le visite di amici e parenti.
E’ una sorta di prigione dorata (vedi il giro notturno di Rudolph nel chiudere a chiave porte e portoni) nelle sembianze del “buon nido borghese”, il cui buio morale è appena rischiarato da qualche atto di misericordia (il cibo lasciato da una ragazzina polacca, domestica degli Höss, nelle zone dove andranno a passare o lavorare i prigionieri del campo).
La glaciale ritualità esistenziale, come scritto del tutto indifferente al male di cui si è causa, negando quanto perpetrato sotto i propri occhi, ci conduce alla nostra attuale visione delle cose, noncuranti di qualsiasi atto di violenza giornaliero, su piccola o larga scala, al di là di qualche indignazione di prammatica magari espressa tramite i social, dimenticando di vedere nel prossimo, “l’ altro da sé”, la valorizzazione di una diversità fondante, quella che ci accomuna tutti in forza di una individualità da preservare e condividere, nel nome di una concreta umanità.

Probabilmente, come credo venga reso emblematico dalla sequenza che precede il finale (le consuete pulizie all’interno dell’ex campo di concentramento, oggi plesso museale), è più facile istituzionalizzare il ricordo che porre in essere un’empatica condivisione volta ad accomunare i crimini passati, quelli attuali ed una concreta lotta perché non si ripetano più in futuro. “Noi siamo la memoria che abbiamo e la responsabilità che ci assumiamo. Senza memoria non esistiamo e senza responsabilità forse non meritiamo di esistere” (José Saramago).
Anche La sala professori, scritto (insieme a Johannes Duncker) e diretto da İlker Çatak, presentato alla 73ma Berlinale e candidato agli Oscar come Miglior Film Internazionale in rappresentanza della Germania, visualizza una struttura scenica in guisa di congruo microcosmo, rappresentativo dell’odierno vivere sociale, ma non un’ abitazione civile, bensì un moderno edificio scolastico, soffermandosi in particolare sulle vicende inerenti alunni e professori di una II Media.

L’andamento narrativo si dipana in virtù di una suadente coesione tra sceneggiatura, regia, fotografia (Judith Kaufmann), montaggio (Gesa Jäger) e colonna sonora (Marvin Miller), quest’ultima idonea a conferire una caratterizzazione da thriller, cui va ad aggiungersi quale colonna portante l’intensa interpretazione di Leonie Benesch nei panni di Carla Nowak, professoressa di Matematica ed Educazione Fisica.
Il suo vibrante idealismo dovrà però fare i conti con una realtà al cui interno il confine tra giusto e sbagliato non sarà mai propriamente netto, fino a rivestirsi di varie ambiguità e storture nella ricerca e conseguente proclamazione della verità riguardo un determinato accadimento. Tutto ha inizio con una riunione in sala professori, dove, all’insegna della tolleranza zero professata a piè sospinto dalla dirigente scolastica (Anne-Kathrin Gummich), i docenti stanno cercando d’individuare chi possa aver commesso una serie di furti, denaro ed oggetti vari, all’interno della scuola, chiedendo anche la collaborazione dei due rappresentanti degli studenti, per quanto piuttosto vicina ad una sottile coercizione, come fa notare la professoressa Nowak.
L’accusa cade su di un ragazzino turco, Ali (Can Rodenbostel), trovato in possesso di un’ingente somma una volta chiesta la consegna dei portafogli all’intera classe, anche se l’intervento dei genitori si rivelerà poi provvidenziale, avevano loro dato dei soldi al figlio perché potesse comperare un videogioco. La professoressa Nowak a questo punto vorrebbe individuare il vero colpevole: lascia la videocamera del laptop accesa, nella sua postazione in sala professori, insieme alla giacca col borsello nella tasca, andando a generare una reazione a catena dagli esiti imprevedibili…
Çatak “pedina” la protagonista quale simbolo di un’idealizzata giustizia, riprendendone ogni atteggiamento nei confronti dei vari avvenimenti, facendo così risaltare ogni aspetto della sua personalità. Racchiude all’interno dell’ “antico” formato 4:3 la teatralizzazione di un dilemma etico che da particolare volge all’universale, anche considerando come non venga offerta alcuna caratterizzazione che consenta d’individuare la cittadina sul cui territorio sorge la struttura scolastica, al pari di ciò che potrebbe riguardare la sfera privata della professoressa Nowak, origini polacche a parte.
Cos’è dunque la verità? Non una rivelazione che si rivesta dei caratteri di una, forse auspicabile, assolutezza tout court, bensì un’ esternazione dai molteplici risvolti ed ognuno di questi andrà a coincidere con l’adattamento ad una personale visione esistenziale, propria dei professori così come degli studenti (anche attraverso il giornale scolastico) e dei loro genitori.
La scuola, in quanto istituzione, si concretizza quale paradigma di ciò che si verifica nella vita sociale di ogni giorno, tra diritti affermati e altri negati, pregiudizi duri a morire, un giornalismo lontano da ideali di trasparenza e veridicità nel riportare le notizie, nell’ambito di un sistema che si alimenta delle proprie contraddizioni per preservare la sua stessa continuità d’esercizio, all’interno del quale risulta difficile esternare la propria individualità, idonea a porre in essere una necessaria diversificazione.
Un aspetto quest’ultimo che viene sublimato nell’intenso finale, risultante dalla combinazione di differenti visuali non comportanti propriamente una soluzione, ma l’elusività inerente a differenti verità, riprendendo in chiusura quanto scritto nell’articolo, nella difficoltà evidente di addivenire ad un punto comune di conciliazione, pur nella sostanziale diversità di vedute.
La zona d’interesse e La sala professori, andando a concludere, rappresentano entrambi, a parere dello scrivente, la concreta espressione, visiva e contenutistica, di un “cinema altro”, incline a sostenere non tanto, o non solo, lo stupore dello sguardo, quanto, in particolare, la necessità di stimolare delle domande, invitandoci a riflettere su quello che siamo stati, sulla nostra attualità e sul nostro divenire.
Immagini di copertina: Movieplayer






Lascia un commento