
New York, fine anni’80. Marion Post (Gena Rowlands), direttrice della Facoltà di Filosofia in un college femminile, sposata con Ken (Ian Holm), cardiologo, giunta al classico giro di boa dei cinquant’anni si ritiene complessivamente soddisfatta della propria vita, tanto da un punto di vista personale che professionale, anche se al riguardo dichiara di “non voler scavare”, in quanto “se una cosa sembra funzionare, meglio non toccarla”. Marion e Ken sono ambedue al secondo matrimonio e l’uomo è padre di una figlia sedicenne, che vive con l’ex moglie. La ragazza va a trovarli spesso e sembra aver instaurato con la matrigna un rapporto amicale. Chiesto il congedo per potersi dedicare alla scrittura di un libro, Marion, infastidita dal rumore causato dai lavori in corso nell’appartamento dei vicini, prende in subaffitto un bilocale in centro, che sarà quindi il suo studio-rifugio.
Un giorno, causalmente, avverte delle voci provenire dalla grata dell’impianto di aerazione, nello studio psichiatrico a fianco è in corso una seduta, un paziente sta confidando all’analista la propria omosessualità e Marion rimedia a tale bizzarro disguido architettonico ponendo sulla griglia un cuscino del divano, anche se da lì a poco andrà a levarlo, incuriosita dalla voce angosciata di una donna (Mia Farrow), incinta, la cui insicurezza esistenziale l’ha spinta sull’orlo del suicidio, percependo il vuoto e la falsità dei propri gesti ed atteggiamenti. Ascoltandone la storia, Marion rivivrà, rielaborandone il ricordo, tutti quei momenti della propria vita che aveva forzatamente messo all’angolo, celandosi dietro la spessa maschera dell’irreprensibilità, nella vita sociale ma in particolare nei legami familiari col fratello Paul (Harris Yulin) e la di lui moglie Lynn (Frances Conroy), coi genitori, col precedente marito Sam, morto suicida, e quello attuale, un rapporto irreggimentato nella ritualità borghese dopo gli slanci iniziali.
Riaffiora poi il doloroso ricordo di un aborto, fino a rivivere le sensazioni del profondo amore, reciproco, verso Larry (Gene Hackman), “rosa non colta”, che, insieme alla conoscenza di Hope, la donna in cura dallo psichiatra, darà comunque un inedito impulso alla sua vita… Per ricordare l’attrice Gena Rowlands, che ci ha lasciati lo scorso 14 agosto, interprete dotata di un naturale carisma, che le ha consentito di portare in scena una recitazione tanto emozionalmente intensa nel dare rilevanza alle note introspettive dei personaggi quanto dolorosamente realistica, ho scelto di scrivere del film Another Woman, sceneggiato e diretto da Woody Allen. Una preferenza motivata sia dalla circostanza che la pellicola in esame rappresenta il suo ritorno sul grande schermo dopo la morte del marito, il regista John Cassavetes, sia perché, a parere dello scrivente, qui la Rowlands offre un’ulteriore esaltazione delle sue doti recitative.
Quest’ultime pongono infatti in rilievo l’interiorizzazione messa in atto dal personaggio di Marion riguardo la propria emotività, tenuta sotto controllo, ingabbiata, ancor prima che dalle convenzioni sociali inerenti alla middle class newyorkese, da un comportamento oltremodo razionale nel relazionarsi con quanti le sono vicino, inibendo il proprio Io, mantenendo una calcolata presa di distanza da quegli stimoli che comunque il mondo circostante continua ad inviarle. Allen rende omaggio all’amato collega Ingmar Bergman nel porre in scena determinati simbolismi che consentono a noi spettatori di compiere insieme alla protagonista un vivido percorso catartico, reso ulteriormente pregnante dal lavoro sulla fotografia ad opera di Sven Nykvist, collaboratore del cineasta svedese in venti film.
Nykvist asseconda con naturalezza quanto espresso nell’ambito della sceneggiatura per il tramite di tonalità idonee a rimarcare il continuo rincorrersi fra la realtà, i sogni che si trasmutano in ricordi e rimembranze che volgono al sogno. Ecco allora che l’elemento onirico viene visualizzato e reso tangibile quale opportuno mezzo elaborativo dell’inconscio: in tal modo, quanto soffocato da una ritualità esistenziale opprimente, con la vera personale essenza celata dalla maschera della convenzionalità, potrà scaturire definitivamente all’esterno, consentendo un confronto con se stessi e il mondo circostante, tra eventi di cui non si era probabilmente a conoscenza (il tradimento messo in atto dal marito, per esempio), ma che si sarebbero potuti e dovuti intuire se Marion avesse dato adito ad una maggiore sensibilità, comunque insita in lei.

Alla fine del suo percorso, nel prospettarsi della donna che è stata e di quella che avrebbe potuta essere, andrà allora a delinearsi una riconciliazione compensatrice tra un passato che non torna, se non come senso di opportunità perduta, e il monito nel vivere meglio l’oggi che rimane, qui e ora, assecondando il fluire temporale, accettandone, volenti o nolenti, ogni possibile variazione sul tema. “Provai uno strano miscuglio di malinconia e di speranza, mi chiesi se un ricordo è qualcosa che hai o qualcosa che hai perduto. Per la prima volta, dopo tanto tempo, mi sentii placata”, sono le parole di Marion che vanno a chiudere un film certo particolare nella filmografia di Allen, per stessa ammissione dell’autore molto europeo nella sua evidente intellettualità.
Un’opera ottimamente scritta, diretta ed interpretata, senza dimenticare la suadente colonna sonora che mescola con disinvoltura le note di autori diversi tra loro (Bach, Malher, Cole Porter, tra gli altri), sulla cui narrazione va a stagliarsi uno tra i ritratti femminili più intensi della storia del cinema, inerente ad una donna che, nel dare ascolto alla propria coscienza, si libera da travestimenti e pastoie varie, accettando definitivamente la propria individualità, rischiarata dalla luce di un Io ritrovato.
Pubblicato su Diari di Cineclub 131/Ottobre 2024- Immagine di copertina: Movieplayer



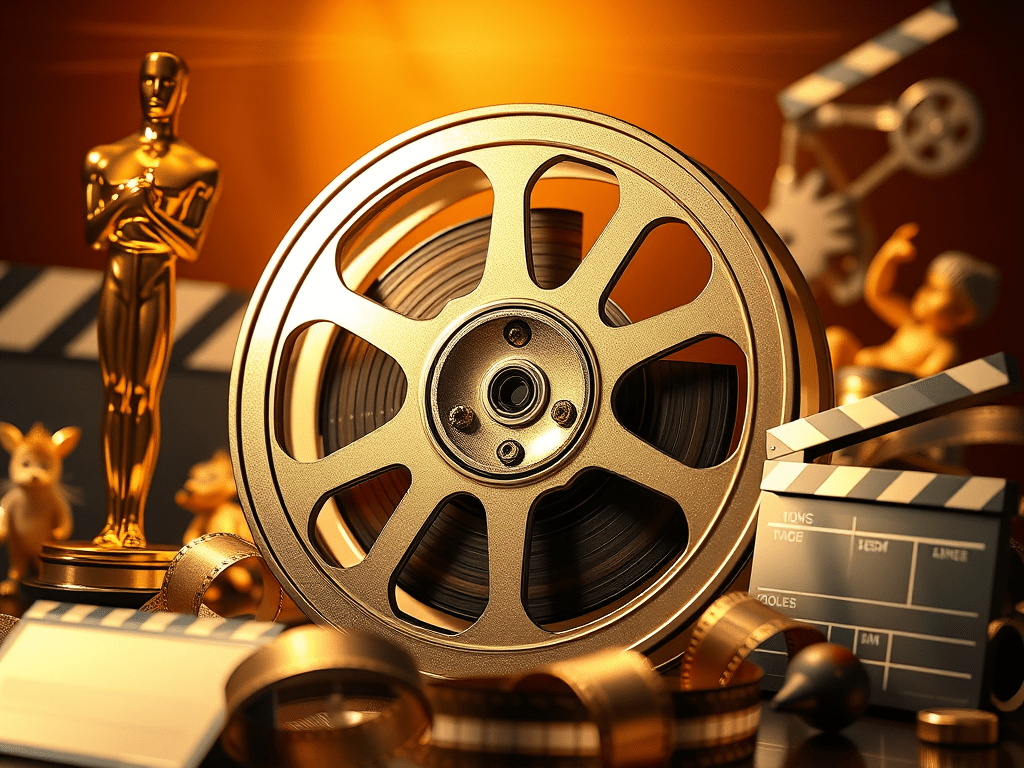

Lascia un commento