
La 17ma edizione di Youngabout International Film Festival, manifestazione cinematografica rivolta alle giovani generazioni attualmente in corso di svolgimento a Bologna (24 novembre-7 dicembre) dopo l’anteprima che ha avuto luogo dall’8 al 10 novembre, conferma sempre di più l’attenzione verso un cinema capace di rivolgersi all’universo giovanile con modalità dirette e mai banali.
Gli si offre infatti, attraverso la visione di opere distanti dalle abituali proposte in sala, l’elaborazione critica di quelle situazioni e problematiche proprie di un percorso formativo, il tutto sostenuto da una funzionale sinergia tra l’apparato organizzativo del Festival e il corpo docente di numerose scuole del territorio che vi aderiscono.
Nel prendere parte alla kermesse, ho scelto di visionare i film selezionati per le scuole secondarie di primo e secondo grado, proiettati di mattina al Cinema Odeon, in lingua originale con sottotitoli, e andrò quindi a riportare le mie impressioni all’interno di una serie d’articoli.
Vado ad iniziare con Desperté con un sueño, coproduzione argentina-uruguaiana per la regia di Pablo Solarz, anche autore della sceneggiatura. L’adolescente Felipe (Lucas Ferro) vive a La Paloma, un distretto del Paraguay, insieme alla madre Mara (Romina Peluffo), sofferente di crisi depressive dopo la morte del marito.

Una situazione non facile per il ragazzo, che tra la scuola e le scorrazzate in bicicletta con gli amici lungo le arterie cittadine coltiva il sogno di divenire attore, frequentando un corso di recitazione, oltra a trasferire su carta quei sogni, anche ad occhi aperti, che gli consentono una più accettabile visione della realtà.
Di questa sua passione, appoggiata dall’insegnante che ne riconosce il talento, invitandolo a prendere parte ad un provino per un film a Montevideo, Felipe non ha però detto nulla a Mara, sapendo di contrariarla. Si recherà quindi di nascosto nella capitale uruguaiana, avanzando la consueta bugia di prendere parte ad una partita di calcio.
Qui andrà a chiedere ospitalità alla nonna paterna Sonia (Mirella Pascual), venendo a conoscenza di determinate vicende legate allo scomparso genitore, affermato attore teatrale…
Solarz mette in scena un intenso racconto di formazione, incline a proporci una narrazione in divenire, ovvero propensa ad assecondare l’andamento degli accadimenti come se si verificassero “qui ed ora”, per quanto mediati dal filtro di un valido lavoro di scrittura, che lascia anche opportuno spazio al non detto, evitando ogni didascalismo di sorta.
L’autore avalla quindi la percorrenza visuale di un doppio binario tra fantasia e realtà, grazie anche all’intensa e realistica interpretazione del giovane Lucas Ferro, che offre a Felipe quella variabile umbratile propria di chi si accinge al passaggio dall’adolescenza alla delicata fase che lo condurrà alla vita adulta, elargendo sostanza recitativa anche ai silenzi, in virtù di una non comune espressività dello sguardo.
La vita imita l’arte più di quanto l’arte imiti la vita sosteneva Oscar Wilde, e così vediamo Felipe intraprendere una recita in duplice veste, quella rivolta alla madre nel nasconderle il proprio sogno e l’altra più propriamente attoriale, giungendo infine ad annullare la distanza tra realtà e fantasia nel corso del fatidico provino, che assumerà un’inedita consistenza catartica, fino a comportare, probabilmente, una definitiva assunzione di responsabilità nei confronti della vita.
Desperté con un sueño si alimenta narrativamente del descritto parallelismo tra i due piani del mondo reale e di quello onirico, la cui confluenza, in odore di reciprocità, fa sì che quanto anelato da Felipe assuma concretezza fino alla consapevolezza della propria più intima essenza, nel pieno rispetto della personale inclinazione. Una realizzazione certo pregevole, capace di coniugare con garbo intimità ed empatia.
Più propriamente calato nella realtà mi è parso invece Dojo, film olandese che vede alla regia Boris Paval Conen, mentre la sceneggiatura è opera di Joost Schrickx, Evianne Lamme, Ashar Medina. Brandon (Kymani Pinas), tredici anni, vive in un quartiere periferico olandese, dove la visione di spazi verdi si alterna a quella grigia ed uniforme dei tanti “alveari di cemento”, come quello in cui, all’interno di un modesto appartamento, il ragazzo risiede insieme alla sorella e i genitori.
Quest’ultimi con i rispettivi lavori si danno da fare per assicurare alla famiglia quanto basta al necessario sostentamento. Ma al ragazzo, così come all’amico del cuore Stefano (Delano Watchman), tutto ciò non sembra essere sufficiente, anelando a possedere quanto fa status presso i propri coetanei, tra videogiochi e l’ultimo modello di smartphone.
Ecco perché si sono messi al servizio di Billy (Ramsesuan Hall) e della sua cricca, agendo come pali o andando ad indicare qualche buon colpo. E così i due, per entrare definitivamente nelle grazie del capobanda, si introducono in un costruendo dojo, per impossessarsi di un tablet, ma vengono sorpresi dal titolare, l’istruttore Kai (Emmanuel Ohene Boafo), che riesce ad acciuffare Brandon, ponendolo di fronte ad un’alternativa: la denuncia alla polizia o seguire le sue lezioni di judo…
Nel corso della visione di Dojo, sono rimasto favorevolmente colpito più che dalla sceneggiatura, in fondo non del tutto dissimile da altre realizzazioni incentrate sulla tematica dello sport quale mezzo di redenzione e riscatto sociale, nonché coadiuvante nell’affermazione della propria personalità, dalle valide intuizioni registiche intese a restituirci lo sguardo di Brandon nell’osservare la realtà che lo circonda.
Evitando infatti la fascinazione visiva che potrebbe derivare dalla spettacolarizzazione della violenza, Conen riesce a dare congrua tangibilità visiva al sobborgo olandese quale “mondo a parte”, microcosmo rappresentativo di ogni ambiente dove, nella mancanza di qualsivoglia riferimento istituzionale e culturale, e solo qualche famiglia a difendere con fatica la disgregazione silente di ogni valore propriamente umano (esemplare al riguardo la figura del padre di Brandon), risulterà difficile per un adolescente preservare la potenziale purezza comportamentale nel percorso a tappe che lo porterà verso l’età adulta, nel cui ambito la rilevanza trainante di sentimenti quali l’amicizia e l’amore potrebbe vedersi annientato quello slancio spensierato e gioioso proprio dell’età.
Nel sopravanzare di una logica comportante più di una difficoltà nel discernere su cosa sia bene e cosa sia male, le due entità andranno a confondere o sovrapporre i rispettivi confini, fino ad assumere contorni ambigui ed indefiniti, tanto da ritenere che la felicità possa anche essere costituita dall’acquisizione emulativa di quanto la parabola consumistica impone quali status convenzionali del benessere.
Ecco allora che la pratica dello judo si rivelerà fondamentale, nel suo significato concreto e metaforico, per Brandon, come, di riflesso, per Stefano: se nella vita è inevitabile incorrere in una o più cadute, sarà allora necessario tanto apprendere come finire a terra senza farsi troppo male, quanto, in particolar modo, fare di tutto per rimettersi in piedi e difendersi nei riguardi di tutto ciò che potenzialmente possa minacciare il possibile raggiungimento della propria individualità, idonea quest’ ultima a fare la differenza nel “mare magnum” rappresentato dall’omologazione livellatrice.
Un film, andando a concludere, che fa dell’essere al contempo semplice e diretto il suo punto di forza, illustrando ai giovani spettatori, e rammentando a noi adulti, sia il concetto di come “la vita di ogni essere umano sia legata ad altre vite” (It’s A Wonderful Life, Frank Capra, 1946), sia il rilievo che può assumere, all’interno di una comunità che voglia definirsi sociale, la reciproca confluenza di comprensione e partecipazione umana.

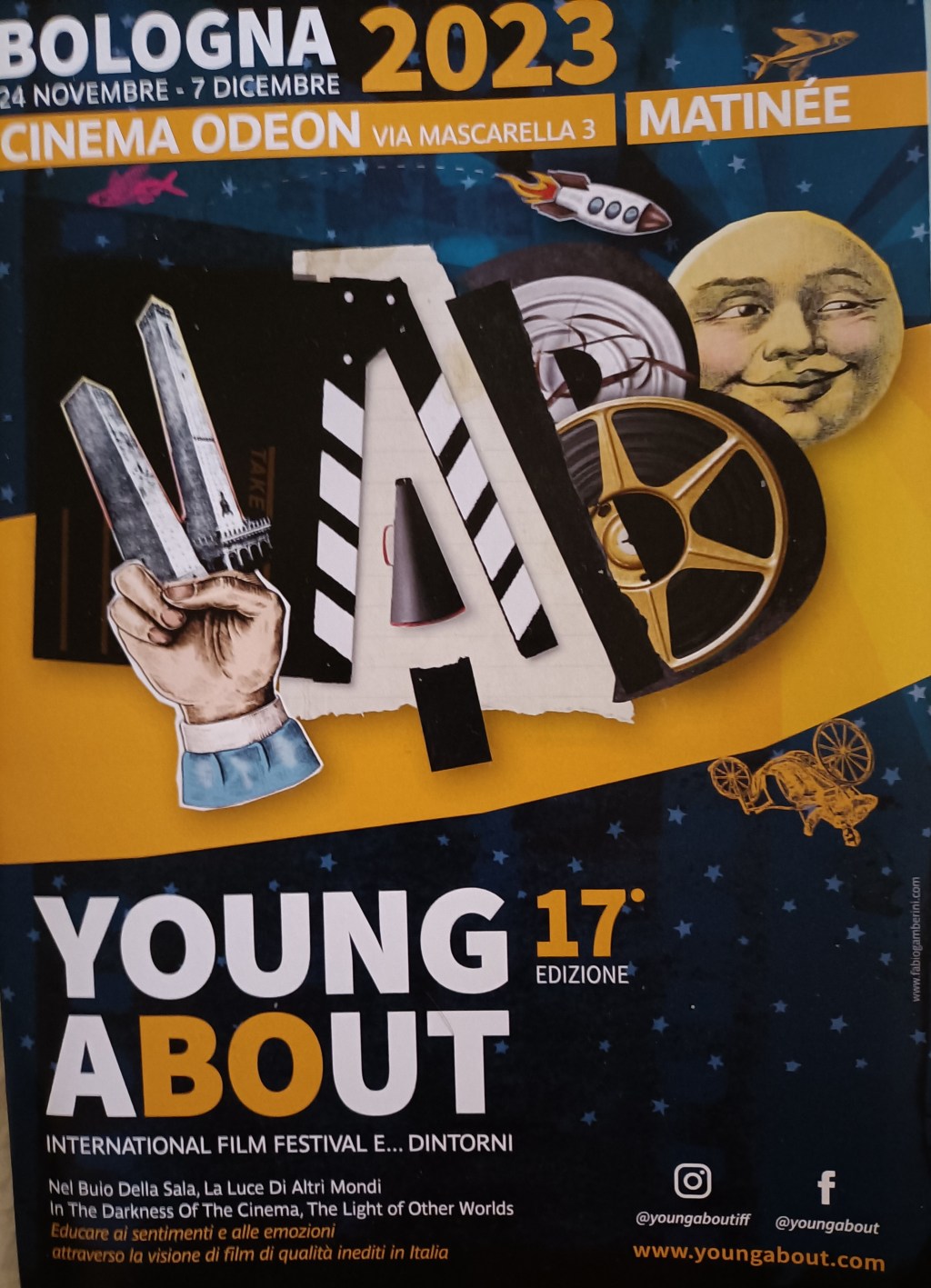

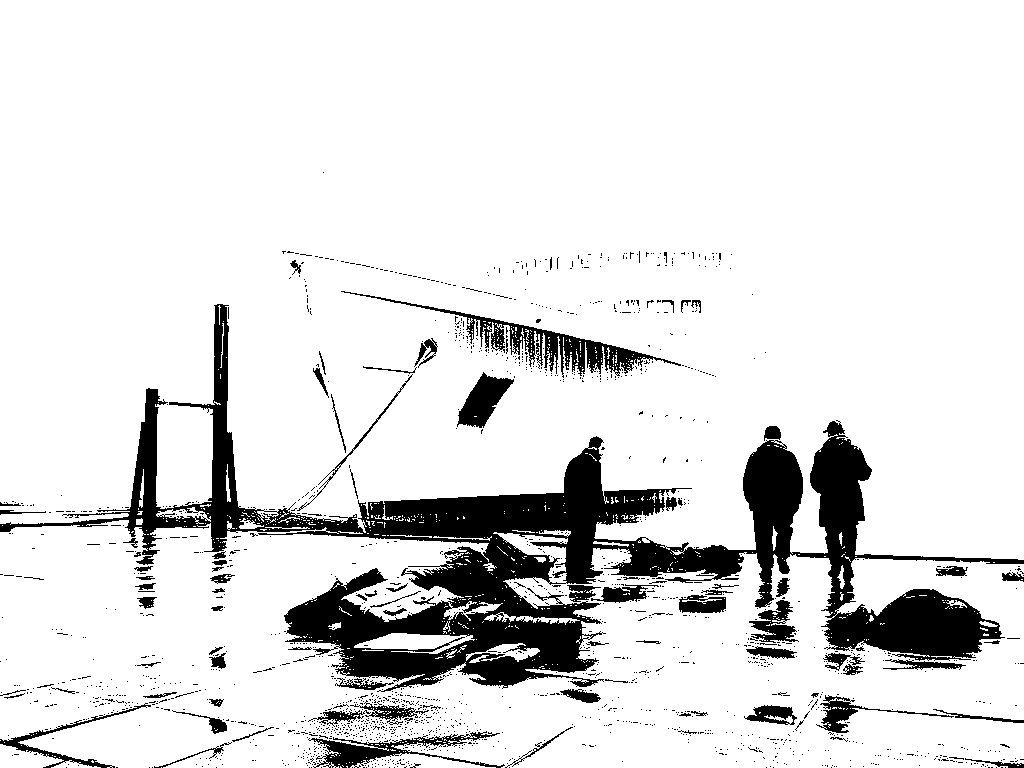

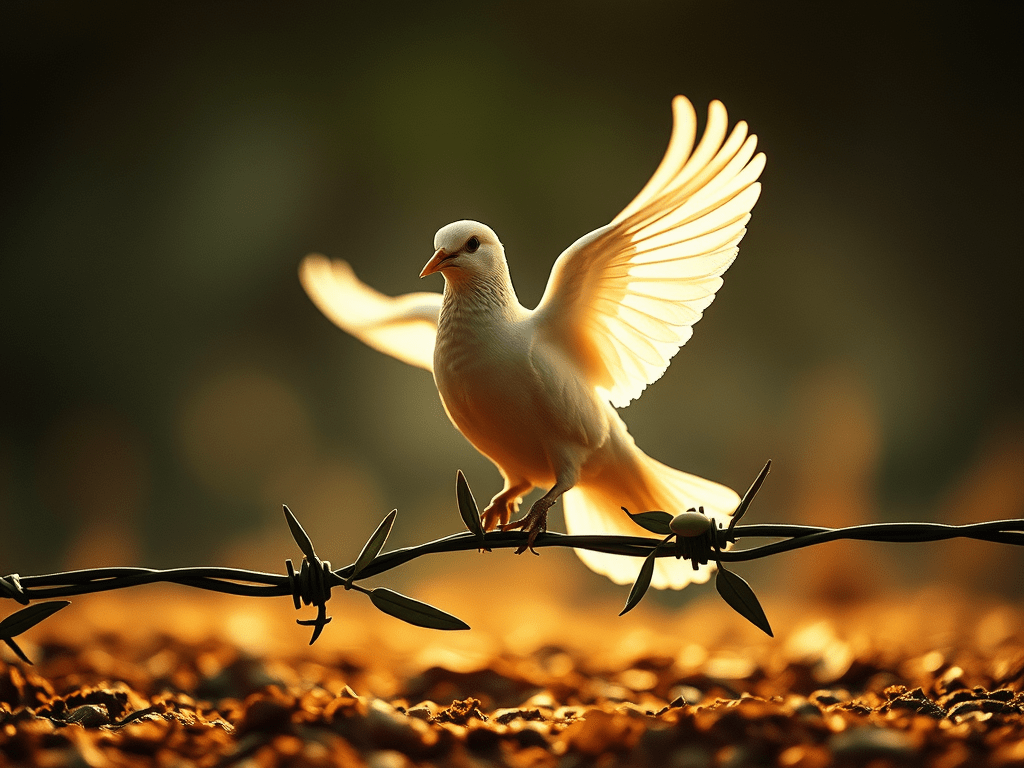
Lascia un commento