Lo scorso 15 giugno ci ha lasciati Rinaldo Smordoni (Roma, 1933), protagonista esordiente, “preso dalla strada”, per usare l’espressione del tempo, del film Sciuscià di Vittorio De Sica, 1946, così come il sodale Franco Interlenghi. Rivestivano i panni, rispettivamente, di Giuseppe e Pasquale, due ragazzi di 15 anni che, nella Roma del secondo dopoguerra, occupata dagli Americani, tirano a campare, egualmente ad altri minori, lavorando come lustrascarpe oppure arrangiandosi con vari espedienti, quando non vengono impiegati come manovalanza di coadiuvo per qualche colpo da quegli adulti privi di scrupoli e ormai refrattari a qualsivoglia senso di umanità.
Al contrario di Interlenghi, che dopo essersi calato in questo ruolo intraprese una carriera cinematografica di tutto rispetto, Smordoni si allontanò dal mondo della Settima Arte, dopo aver interpretato, nel 1948, Gavroche in Caccia all’uomo, prima parte de I miserabili per la regia di Riccardo Freda, adattamento dell’omonimo romanzo di Victor Hugo, pellicola che per la sua lunghezza venne distribuita divisa in due episodi (il secondo fu Tempesta su Parigi) e aver infine recitato, nello stesso anno, in 11 uomini e un pallone, diretto da Giorgio Simonelli.
Una volta adulto, Smordoni lavorò dapprima come marmista e poi divenne autista di tram, prendendo parte a due documentari di Mimmo Verdesca dedicati al capolavoro di De Sica, Protagonisti per sempre (2014) e Sciuscià 70 (2016). Resterà per sempre indelebile il ricordo di quella sua prima interpretazione, la spontaneità immedesimativa resa nell’offrire al personaggio del piccolo Giuseppe, così come Interlenghi riguardo quello di Pasquale, tutta l’ingenuità propria della fanciullezza e della fantasia resistente, entrambe sporcate dall’agire di quanti si rivelano propensi ad ammorbarne la purezza dei sogni e la costanza di una speranza sottesa verso la concretezza di un domani se non migliore quantomeno diverso nell’offrire determinate opportunità, all’interno di un necessario e graduale percorso di crescita.
Sciuscià ricevette una candidatura ai premi Oscar per la migliore sceneggiatura (opera di Sergio Amidei, Adolfo Franci, Cesare Giulio Viola e Cesare Zavattini), conseguendone, primo film straniero, uno “Speciale” (l’apposita categoria venne istituita nel 1956), riconoscimento cui si aggiunse il Nastro d’Argento 1947 per la regia (ex aequo con Un giorno della vita, di Alessandro Blasetti).

La narrazione alterna riprese lungo le arterie cittadine, sfruttando la luce naturale, a quelle degli interni ricostruiti in studio (Teatri della Scalera), riproducenti il carcere minorile San Michele dove verranno rinchiusi (“merce nuova”) i due giovani, una volta riconosciuti dalla chiromante cui avevano venduto coperte americane su commissione del Panza (Gino Saltamerenda), losco individuo dedito al traffico illecito che li ha usati, insieme ad Attilio (Guido Gentili), fratello di Giuseppe, per perpetrare un furto a casa della donna.
Quanto ottenuto per il servizio, congiunto alla somma messa da parte lavorando come sciuscià (lustrascarpe di strada nell’idioma napoletano, dall’inglese shoeshine) e dandosi da fare in qualche traffico di borsa nera, era servito loro per realizzare un sogno, comprare un cavallo bianco, Bersagliere, in groppa al quale hanno potuto godersi solo qualche breve cavalcata: finiti in cella, separati l’uno dall’altro, i due andranno a conoscere una quotidianità ancora più atroce di quella vissuta finora, un vero e proprio mondo a parte alle cui regole dovranno giocoforza adattarsi, costretti a divenire adulti anzitempo, fino all’ottundimento delle proprie più intime emozionalità, tra violenze e menzogne, subite e praticate, a rimarcare l’ormai perduta innocenza…

Se con I bambini ci guardano, 1943, tratto dal romanzo Pricò di Cesare Giulio Viola, De Sica aveva già affrontato le tematiche inerenti al disagio infantile all’interno di una società insensibile o comunque distratta, con Sciuscià lo sguardo si sposta dal “buon nido borghese”, ritratto con crudo realismo, al disadorno vissuto giornaliero della strada, visualizzando, tra miseria e disperazione, gli accadimenti che vanno a materializzarsi dinnanzi la macchina da presa, focalizzando l’azione del momento, come se si stesse verificando “qui ed ora”, alternando oggettività e soggettività.
Emblematica al riguardo la sequenza dell’arresto di Giuseppe e Pasquale, condotti all’interno del cellulare che li condurrà nell’istituto di pena, come fa notare Gian Piero Brunetta ne Il cinema neorealista italiano. Da Roma città aperta a I soliti ignoti (Edizioni Laterza, 2009). L’obiettivo dapprima si sofferma sullo sguardo di una loro coetanea, per poi subito mutare prospettiva in quello dei ragazzini intenti ad osservare attraverso le sbarre del furgone la realtà che stanno lasciando e, subito dopo, quella che dovranno affrontare a breve, ormai giunti a destinazione.

Illuminante poi la sequenza relativa al processo, quando gli organi giudicanti riveleranno la stolidità propria di quanti hanno soppresso ormai da tempo il fanciullino di pascoliana memoria, nel non voler credere alle parole di Giuseppe e Pasquale, una volta che affermeranno di aver comperato Bersagliere semplicemente per il piacere di cavalcarlo.
La resa visiva è disadorna, non vi è sentore di alcun compiacimento o pietismo, bensì semplicemente la cruda rappresentazione di una denuncia sociale e civile, che all’interno del carcere minorile, con la fotografia (Anchise Brizzi) a ricercare un’illuminazione richiamante le tonalità cupe dell’espressionismo, abbandona quella sospensione tra favola e film verità, il surrealismo fiabesco caro a Zavattini (il cavallo bianco, utopico simbolo di migliori condizioni di vita, oltre che della giovinezza ed innocenza perdute) proprio della prima parte, fino all’ingresso nell’istituto di pena.

Rimane salda la costanza della “poetica del pedinamento”(la macchina da presa che si muove al passo dei personaggi), ma ora l’obiettivo si rende maggiormente indagatore dei dettagli, ricerca sui volti dei ragazzi ogni espressione che ne possa evidenziare il costretto mutamento dei loro atteggiamenti caratteriali, esternando un atto d’accusa contro il sistema di giudizio e carcerazione dei minori, comportante più che una vera e propria rieducazione l’innalzamento alla massima potenza della violenza sopraffattrice già conosciuta al di fuori di quelle mura, specularmente propria tanto degli adulti quanto dei giovani, a rappresentare due eserciti “l’un contro l’altro armati”.
Qui l’iter narrativo diviene in crescendo, fino a raggiungere picchi di realistica tragicità, senza mai volgere al melodramma, per poi trovare ulteriore dolente sfogo nel finale, quando il grido di dolore di Pasquale risveglierà la nostra coscienza, squarciando l’ovattato velo della quotidiana indifferenza, spingendoci a gridare con lui per le tante ingiustizie e violenze che ancora oggi i più deboli sono costretti a sopportare, sacrificando la propria individualità sull’altare della prevaricazione totalizzante.
Abusi propri di ogni ambiente dove, anche considerando la disgregazione silente di qualsiasi valore umano cui fare riferimento, più che la possibilità di meditare su cosa sia bene e cosa sia male si è indotti ad assecondare una logica che vede le due entità confondere o sovrapporre i rispettivi confini, tanto da assumere contorni ambigui ed indefiniti.
Una lotta senza fine, che richiederà sempre nuove vittime sacrificali, nell’ambito di una effimera sopravvivenza, sospesa nei meandri di un indefinito limbo al cui interno non si sarà mai propriamente adulti così come non si è mai stati propriamente fanciulli e dove, forse, “morire è l’unico modo per ricordarci che anche loro erano vivi”, citando ed adattando in chiusura le parole del regista impersonato da Orson Welles ne La ricotta di Pier Paolo Pasolini, episodio del film collettivo Ro.Go.Pa.G., 1963.
Immagine di copertina: Wikipedia



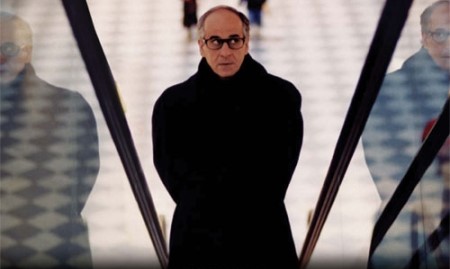


Lascia un commento